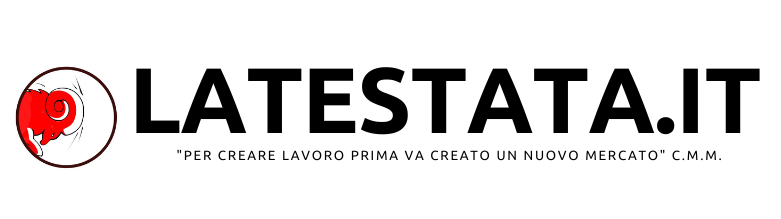Il pagamento ritardato dei trattamenti di fine servizio si pone in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione e, al contempo, con il principio di adeguatezza dei mezzi per la vecchiaia.
È quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 19 giugno 2023 la quale, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sollecita un intervento riformatore del legislatore ed evidenzia come la corresponsione differita e rateale dell’indennità di fine servizio ai dipendenti pubblici sia in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione, espresso dall’art. 36 della Costituzione, e, al contempo, attesa la sua natura previdenziale, con il principio di adeguatezza dei mezzi per la vecchiaia dettato dall’art. 38 della Costituzione.
Gli Ermellini, dopo aver ricostruito il quadro normativo in cui si inseriscono le disposizioni censurate, rilevano quanto segue:
Secondo la Corte, l’evoluzione normativa ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico alle regole dettate nel settore privato dall’art. 2120 del codice civile.
La natura retributiva delle prestazioni trovano riconoscimento nell’art. 36 della Costituzione, essendo il TFS statale di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell’esistenza umana».
La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell’ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione».
Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall’impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che vale a connotare le indennità in esame e che concorre con quella retributiva.
La Corte, tuttavia, è consapevole che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull’equilibrio del bilancio statale. Non è pertanto illegittimo, in assoluto, che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio. Un siffatto intervento è, però, anzitutto, vincolato al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.
Un ulteriore limite riguarda la durata di simili misure. La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è, infatti, condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti.
Ebbene, prosegue la Corte, il termine dilatorio di dodici mesi, quale risultante dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, oggi non rispetta più, né il requisito della temporaneità, né i principi di ragionevolezza e di proporzionalità (…) essendosi trasformato da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale perdendo gradualmente la sua originaria ragionevolezza.
A ciò deve aggiungersi, osserva la Corte, che la perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell’attività lavorativa. Non è, infatti, infrequente che l’emolumento in esame venga utilizzato per sopperire ad esigenze non ordinarie del beneficiario o dei suoi familiari, e la possibilità che tali necessità insorgano nelle more della liquidazione del trattamento espone l’avente diritto ad un pregiudizio che la immediata disponibilità dell’importo eviterebbe.
Al vulnus costituzionale riscontrato (…) la Corte, a conclusione delle motivazioni in sentenza, non può, tuttavia, allo stato, porre rimedio, posto che spetta al legislatore individuare le soluzioni più adeguate.
Il tempo di cui gode il legislatore deve però ritenersi limitato, tenuto anche conto che la Corte Costituzionale in un suo precedente aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.
La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame, conclude la Corte, esige quindi un intervento riformatore prioritario, che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.
Queste le motivazioni in estrema sintesi della sentenza della Consulta in commento.
Quale impatto avrà sui conti pubblici.
Secondo le prime stime Inps, i primi effetti applicativi costerà 15-16 miliardi di euro.
Sul fronte sindacale, le parti sociali chiedono immediata e piena tutela per i lavoratori e le lavoratrici, minacciando in caso contrario una class action nel caso il governo non si attivi in tempi brevi.