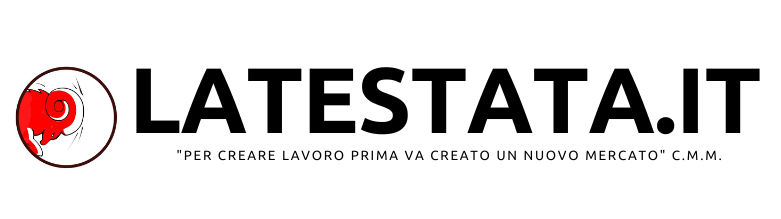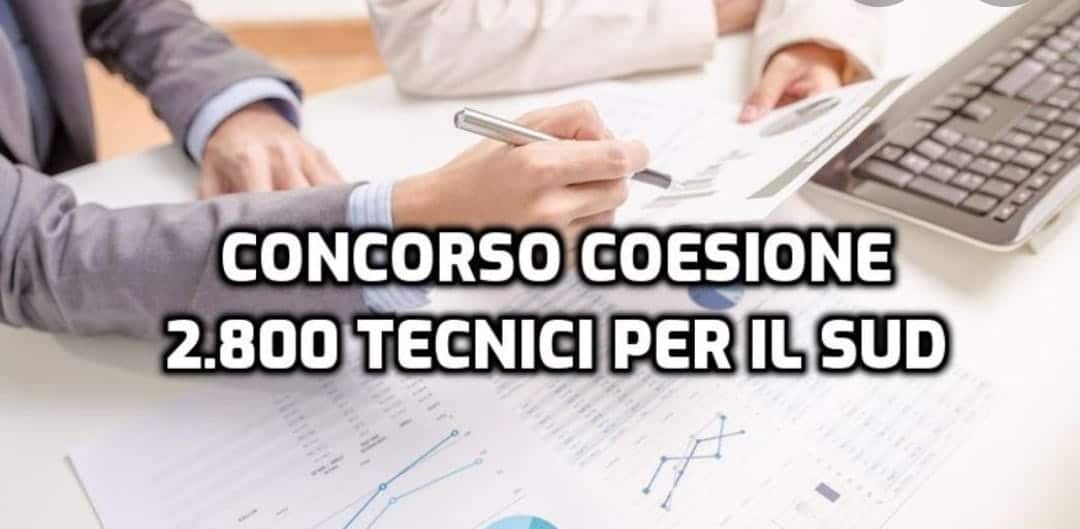Le teorie economiche e alcuni approcci della sociologia contemporanea tendono a descrivere la giornata degli individui come l'esito di un processo razionale di allocazione del tempo totale disponibile. La teoria fondata sul principio della scelta razionale è solo uno dei possibili modelli di spiegazione dell'allocazione del tempo tra le diverse attività quotidiane. Infatti, il tema delle costrizioni nei bilanci temporali individuali, è stato anche teorizzato da Gary Becker, per la prima volta, nel 1965. Secondo l'autore, il bilancio temporale giornaliero di ogni individuo può essere descritto in termini di combinazione obbligata e reciprocamente condizionante tra tempo dedicato al lavoro retribuito e tempo per il consumo. L'acquisto di beni e servizi richiede di dedicare tempo al lavoro retribuito al fine di guadagnare denaro; tempo che viene però sottratto a quello necessario per consumare i beni stessi. In altre parole, a parità di altre condizioni, maggiore è il tempo speso nel guadagnare denaro, minore sarà quello disponibile per consumare i beni e i servizi per godere dei quali è necessario lavorare. Esiste, infine, un terzo livello che concerne l'ammontare del tempo complessivo dedicato alle differenti attività nell'intera società. Infatti, il tempo trascorso da alcune persone in una determinata attività appare in relazione con quello che altri soggetti devono passare dedicandosi ad attività differenti. Così, mentre i clienti di un ristorante trascorrono il proprio tempo serale in una attività di piacere, quelli addetti alla ristorazione lo fanno lavorando. Sembra possibile definire questo livello di analisi dell'utilizzo del tempo come macrosociologico. Le sequenze quotidiane di ogni singolo soggetto determineranno le quantità di tempo dedicate alle singole attività (micro aggregati) che, osservate con riferimento all'intera società, costituiranno le macro dimensioni di utilizzo del tempo, con la conseguenza che modifiche ad uno dei tre livelli determineranno cambiamenti anche negli altri.
Relazioni di condizionamento reciproco sono possibili anche tra il livello micro e quello macro. Per esempio, la scelta di consumare il pranzo in un esercizio pubblico anziché presso la propria abitazione ha effetti, diretti ed indiretti, su diversi fenomeni macro sociali. Direttamente sulla domanda di servizi di ristorazione, indirettamente sull'offerta degli stessi che tenderà con il tempo ad aumentare. Conseguenze possono però essere osservate anche in altri settori: in quello del trasporto pubblico e privato (che avrà un aumento in prossimità dei principali luoghi di offerta), oppure nel settore della vendita al dettaglio (con l'incremento di frequentazione degli esercizi commerciali in occasione dell'orario di pausa pranzo) o ancora in quello dell'occupazione nelle aree economiche coinvolte. Non solo, la pratica di pranzare in un pubblico esercizio da comportamento isolato e occasionale si trasformerà presto in azione normale e persino in stile di vita, coinvolgendo interi gruppi sociali. Tutto questo ovviamente ha conseguenze anche in altri settori, come nell'editoria, che alimenterà, parlandone, le nuove tendenze, nella amministrazione, che proporrà nuove regole, nel mondo dell'opinione e della cultura, che guarderà con interesse o preoccupazione le nuove pratiche sociali e, non per ultimo, nel sistema delle norme sociali, che darà col tempo dignità di valore a comportamenti fino a poco tempo prima considerati inaccettabili. L'insieme delle reciproche relazioni tra livelli di utilizzo del tempo costituisce il modello "ricorsivo" di cui tratta la più recente saggistica anglosassone sul tema, nel quale gli stili di vita quotidiana determinano le strutture sociali che, a loro volta, ne influenzano caratteristiche e dinamiche.