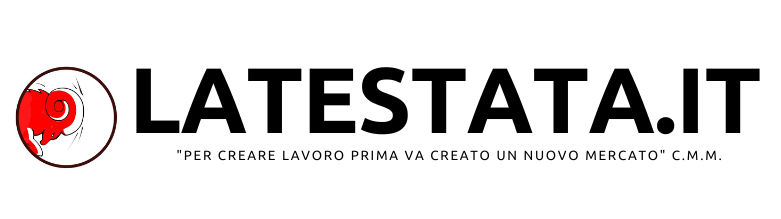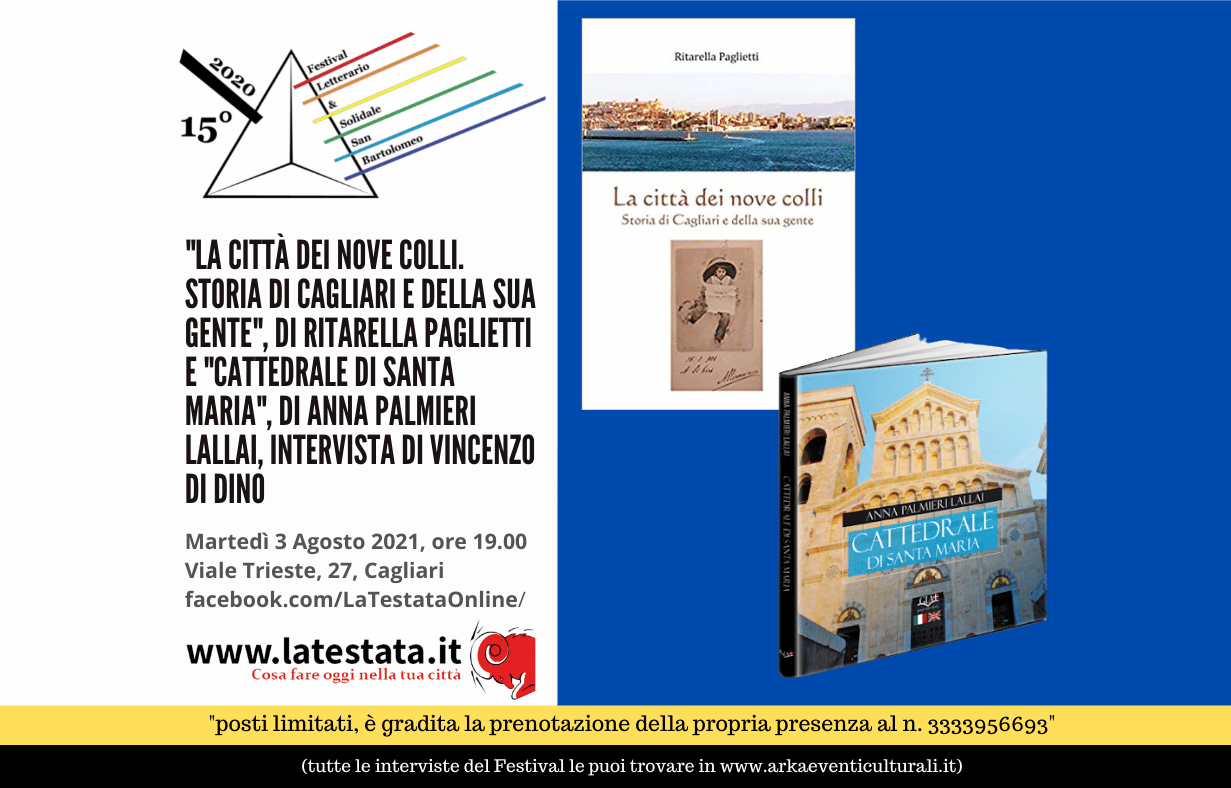A.Y.Gourevitch storico russo del medioevo, disse che le rappresentazioni del tempo sono delle componenti essenziali della coscienza sociale che occupano un posto di primo piano nel ‘modello del mondo’ che caratterizza ogni cultura. L’orientamento verso il tempo e il modo come esso è appreso e vissuto è variabile secondo le epoche e le culture. Lo storico russo constatava quello che oramai tra gli studiosi del tempo è diventato luogo comune: l’uomo contemporaneo maneggia la categoria ’tempo’ con estrema facilità. Infatti, pretende di pianificare la sua attività, di prevedere l’avvenire in tutti i campi, insomma è diventato maestro del tempo, abituandosi a dosarlo, ad economizzarlo e a servirsene in tutti i modi, ma è anche diventato in quale modo ‘schiavo del suo tempo’, perché mai come in quest’epoca, secondo Antonio Del Balzo, l’idea del tempo, della sua irreversibilità della sua fuga e della sua preziosità è stata così dominante. Gli studiosi del tempo affermano che questo tipo di temporalità è una assoluta novità nella storia, da paragonare con il tempo delle società precedenti alla modernità, in modo particolare con il cosiddetto ‘tempo arcaico’ o pre-moderno o tradizionale. A tal proposito, l’antropologo Marshall Sahlins cita la concezione temporale della tribù dei Maori, caratterizzata dall’assenza di una delle dimensioni temporali, quella dell’avvenire, per cui gli avvenimenti non sono unici o nuovi, ma come identici ad un certo avvenimento originale. Per Claude Lévi-Strauss, la coscienza dell’uomo arcaico non è orientata verso il cambiamento, ma è portata a riprodurre integralmente il passato. Ma non si deve dimenticare l’importanza del tema del mito, avanzato per primo da Mircea Eliade, perché l’uomo arcaico si comprende proprio in rapporto alla sua identificazione al mito, che è il primo dispositivo di cui si è servito per controllare il tempo. Infatti, attraverso il mito, egli lega il suo vissuto ad un racconto pregno di affettività, ad una narrazione. Per Lèvi-Strauss, il mito attualizzato dal rito, esalta la funzione del tempo primordiale dell’origine come un tempo forte che è rifugio di ogni nuova creazione. Insomma, l’uomo arcaico non conosce gesto, atto e comportamento che non sia stato vissuto anteriormente da un altro. La sua intenzione è di fare continuamente ciò che è stato già fatto; nel momento in cui riesce a trovare un riferimento a questo passato mitico, l’evento trova il suo senso pieno e così tutto diventa controllabile ai suoi occhi. In qualche modo attraverso questo sistema culturale l’uomo ha cercato di ingannare la morte; l’uomo non lascia spazio né all’individualità né alla temporalità. Il mondo mitico è invaso dal tempo e, allo stesso tempo, il mito è l’unico strumento che l’uomo ha per contrastare il tempo. Gourevitch sottolinea il concetto di ‘tempo mitologico’ col quale si riallaccia all’idea che tutte le modalità del tempo e cioè passato, presente e futuro, sono in qualche modo disposti su di uno stesso piano e, in un certo senso, ‘simultanei’ di fronte al fenomeno della ‘spazializzazione’, con il tempo vissuto nello stesso modo dello spazio. Secondo l’autore, l’uomo antico vede passato e presente estendersi attorno a lui, interpenetrandosi e chiarendosi l’uno con l’altro. Il passato non cessa di durare, ed è per questa ragione che la sua realtà non è inferiore a quella del presente ed è su questa interpretazione che si fondano il culto degli antenati e tutti gli archetipi che si rinnovano nel momento della realizzazione del mito e dei riti. Ma anche l’avvenire partecipa al presente; lo si può vedere esercitare su di esso una influenza magica: di qui le predizioni e le divinazioni; il destino è irrevocabile perché, in un certo senso, ciò che si deve verificare è già un fatto. In ogni caso l’avvenire, percepito come destino, può essere sentito nel presente.