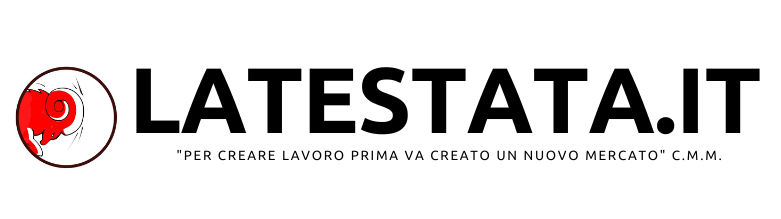Non è trascrivibile in Italia il provvedimento giudiziario straniero, e a maggior ragione l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore non biologico. La decisione della Cassazione.
L’ordinamento italiano vieta la maternità surrogata, pertanto, lo status genitoriale ottenuto all’estero non viene riconosciuto.
L’accordo con il quale una donna si impegna a iniziare e a portare a termine una gravidanza per conto d’altri, rinunciando fin dal principio a far valere i propri diritti sul nascituro, è penalmente vietato dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004.
L’esistenza di tale divieto induce, tuttavia, molti italiani a ricorrere alla surrogazione di maternità all’estero, nei Paesi in cui tale pratica è ammessa.
Quando la surrogazione di maternità è praticata all’estero, sorge il problema del riconoscimento in Italia della genitorialità acquisita all’estero e dello status del nato da maternità surrogata. Problema lasciato irrisolto dal legislatore il quale era stato chiamato a trovare una soluzione adeguata per porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.
Di qui, nell’attesa dell’intervento del legislatore, l’esigenza di assicurare in ogni caso al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini.
Secondo la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 38162/2022 del 30.12.2022 in commento, tale tutela sarebbe garantita dall’istituto dell’adozione in casi particolari, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 55 della legge 5 maggio 1983 n. 184 (diritto del minore a una famiglia) nella parte in cui prevede che l’adozione in “casi particolari” non induce alcun rapporto tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
Ripercorriamo in sintesi i termini dell’articolata vicenda processuale.
Con ricorso promosso davanti alla Corte d’Appello di Venezia, due uomini, cittadini italiani, coniugati in Canada, con matrimonio trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, impugnavano il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona di trascrivere l’atto di nascita del minore nato in Canada, perché contrario all’ordine pubblico e vietato dall’art. 12 della Legge n. 40/2004.
I ricorrenti premettevano che il minore era nato mediante la c.d. gestazione per altri o maternità surrogata. Più segnatamente, deducevano che la fecondazione era avvenuta in vitro tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di uno dei ricorrenti, con successivo impianto dell’embrione nell’utero di una diversa donna, non anonima, che aveva portato a termine la gravidanza e partorito il bambino. Dopo la nascita del minore, le Autorità canadesi avevano formato un atto di nascita nel quale era indicato come unico genitore il ricorrente donatore del proprio gamete (genitore biologico). I ricorrenti, a seguito del ricorso proposto presso la Suprema Corte della British Columbia, venivano entrambi riconosciuti, con sentenza, genitori del minore con conseguente rettifica dell’atto di nascita del bambino in Canada.
Costoro, sulla base del provvedimento della Corte Suprema della British Columbia, hanno chiesto all’Ufficiale dello stato civile italiano di rettificare anche l’atto di nascita del bambino in Italia, che indicava come genitore il solo padre biologico.
L’Ufficiale dello stato civile rifiutava la richiesta, sia perché esisteva già un atto di nascita trascritto, sia per l’assenza di dati normativi certi e di precedenti favorevoli da parte della giurisprudenza di legittimità.
I ricorrenti chiedevano, quindi, a norma dell’art. 67 ex Legge 02.08.1995 n. 218, alla Corte d’Appello di Venezia il riconoscimento in Italia della sentenza straniera, che nelle more (nel frattempo) era passata in giudicato (definitiva non impugnabile), al fine di ottenere la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del minore.
Con Ordinanza del 16.07.2018 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il ricorso e accertava che la sentenza della Corte Suprema della British Columbia possedeva i requisiti per il riconoscimento a norma dell’art. 67 ex Legge n. 218/95.
Avverso l’Ordinanza della Corte d’Appello di Venezia, l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Sindaco in qualità di ufficiale del Governo e del Ministero dell’Interno, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. I genitori del minore, quali esercenti la responsabilità genitoriale, resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale condizionato.
Con Ordinanza interlocutoria, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione del 29.04.2020 disponeva la sospensione del giudizio e dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 6° della Legge n. 40/04, degli artt. 18 del DPR n. 396/2000 e 64 comma 1° lettera g) della Legge n. 218/95, nella parte in cui vietano il riconoscimento e la esecutività, per contrasto con l’ordine pubblico, del provvedimento giudiziario straniero che dispone l’inserimento del c.d. genitore d’intenzione non biologico (colui che non ha dato alcun apporto biologico alla procreazione) nell’atto di stato civile di un minore concepito con le modalità della gestazione per altri o maternità surrogata, per contrasto con gli arti. 2, 3, 30, 31, 117 comma 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27.05.1991 e dell’art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Già Cassazione a Sezioni Unite n. 12193/19 aveva dichiarato che non poteva essere riconosciuto nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che attribuiva lo status di figlio a un bambino nato all’estero mediante gestazione per altri o maternità surrogata in un paese in cui tale pratica era legale, nei confronti del c.d. “genitore di intenzione” a causa del divieto della gestazione per altri o maternità surrogata, previsto dall’art. 12, comma 6, della Legge n. 40 del 2004, divieto posto a tutela dell’ordine pubblico, della dignità della gestante e l’istituto dell’adozione. Per le Sezioni Unite, in questi casi, il genitore d’intenzione doveva ricorrere all’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 l. 184/1983, ossia a quel particolare tipo di adozione, diversa da quella ordinaria, che tutela e riconosce il rapporto affettivo tra il minore e l’adottante (genitore di intenzione) appartenente al medesimo nucleo familiare in cui appartiene l’altro genitore biologico nel quale nucleo il minore aveva già sviluppato legami affettivi significativi.
La Corte Costituzionale, investita della questione, con sentenza n. 33 del 9 marzo 2021, pur dichiarandola inammissibile, ha ritenuto che la stessa “… riguarda la tutela dell’identità del bambino e dei suoi rapporti con la coppia che ha condiviso il percorso che ha portato al suo concepimento e alla sua nascita”. La Corte Costituzionale ha ritenuto quindi di dover valutare la compatibilità del diritto vivente (interpretazione di una norma elaborata dalla giurisprudenza) espresso da Cassazione a Sezioni Unite n. 12193/19 sopra citata con i diritti del minore riconosciuti dalle norme costituzionali e sovranazionali richiamate dal giudice rimettente (che ha rimesso la causa davanti alla Corte Costituzionale).
La Consulta ha concluso affermando che gli Stati possono anche vietare la trascrizione di atti di stato civile o provvedimenti giudiziari stranieri che riconoscano lo status di padre o madre al “genitore d’intenzione”, ma, tuttavia, “deve essere prioritariamente assicurata tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia attraverso un procedimento di adozione effettiva, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato”. A tal fine, la Corte ha ritenuto non adeguato l’istituto dell’adozione “in casi particolari”, in quanto, di fronte a un deficit di tutela del minore “il compito di adeguare il diritto vigente (diritto positivo scritto dal legislatore) alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata, non può che spettare al legislatore affinché trovi una soluzione adeguata per porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”.
A un anno dalla pronuncia della Consulta (Corte Costituzionale), senza che il legislatore sia intervenuto a colmare il deficit di tutela del minore, il Primo Presidente ha assegnato alle S.U. la predetta questione di massima di particolare importanza.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 38162/2022 del 30.12.2022 in commento, nell’attesa dell’intervento, sempre possibile ed auspicabile, del legislatore, trovandosi a dover decidere una questione relativa allo status del figlio di una coppia omoaffettiva, non potendo lasciare i diritti del bambino indefinitamente sospesi, ha ricercato nel complessivo sistema normativo l’interpretazione più idonea ad assicurare, nel caso concreto, la protezione dei beni costituzionali implicati, tenendo conto delle indicazioni enunciate dalla citata sentenza della Corte costituzionale. Su tali presupposti, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci (il diritto del luogo). Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”.