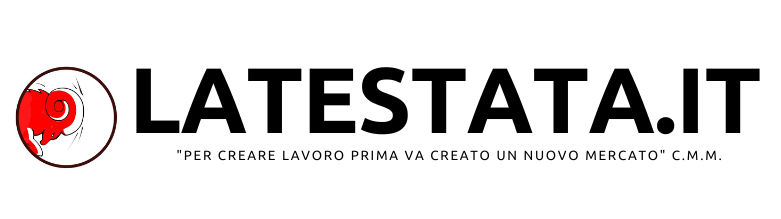In caso di incidente stradale con danni all’autoveicolo, le compagnie di assicurazione non possono rifiutarsi di pagare la riparazione solo perché il costo della stessa sia superiore al suo valore di mercato.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione civile, sezione III, con ordinanza del 20.04.2023 n. 10686 su un caso dove un automobilista aveva richiesto “una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo”.
Il danneggiato, spiegano gli Ermellini, ”può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla (rottamazione e) sostituzione del veicolo danneggiato”: ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile. Soddisfare questa legittima esigenza “può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione”.
Per lungo tempo, tra le compagnie di assicurazione è invalsa la pratica, scorretta e illegale, di imporre al danneggiato la rottamazione dell’auto, rifiutandosi di pagare la riparazione il cui costo risultava di molto superiore al valore di mercato del veicolo danneggiato.
La Cassazione nel censurare detta condotta illecita ha però ricordato un principio generale -che sottende l’intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può comunque eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato.
La norma di riferimento, che di detto principio fa piena applicazione, è l’art. 2058 del c.c. a mente del quale <<il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica (la riparazione), qualora sia in tutto o in parte possibile (comma primo). Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (comma secondo)>>.
Dal dettato normativo emerge chiaramente che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene), costituisce la regola, mentre il risarcimento per equivalente (determinato dalla differenza fra il valore che il veicolo aveva prima del sinistro e quello dopo il sinistro), costituisce l’eccezione, a cui il giudice può aderire quando la riparazione risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.
Cosa deve intendersi per “reintegrazioneeccessivamenteonerosa”.
Sul punto soccorre la Cassazione con l’ordinanza in rassegna la quale spiega che la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per la parte obbligata (debitore danneggiante) “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” e “costituisca una locupletazione (un arricchimento) per ildanneggiato”.
Deve ritenersi, conclude la Corte, ai fini dell’applicazione dell’art. 2058 del c.c., che la verifica di eccessiva onerosità non possa allora basarsi soltanto sull’entità dei costi di riparazione, ma deve anche valutare necessariamente se la riparazione del veicolo (reintegrazione in forma specifica) comporti o meno un indebito arricchimento per il danneggiato, valutazione che varia da caso a caso, da soggetto a soggetto, ostandovi, come già ricordato, il principio -sotteso all’intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato, poiché renderebbe ingiustificata la
condanna del debitore a una prestazione che eccede notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.
In conclusione, da oggi, con l’Ordinanza della Cassazione in commento, le compagnie assicurative potranno rifiutarsi di risarcire il danno mediante reintegrazione in forma specifica (riparazione), solo se dimostrano che la riparazione del veicolo comporti anche un indebito arricchimento per il danneggiato.